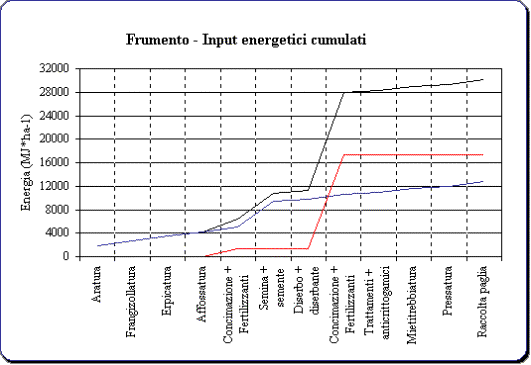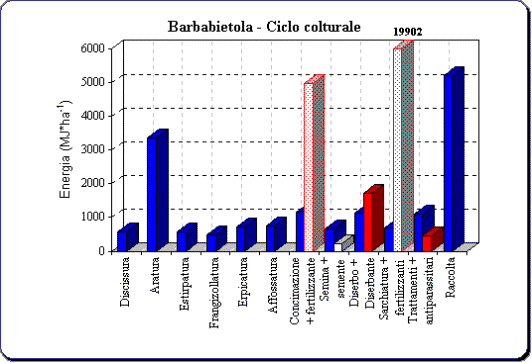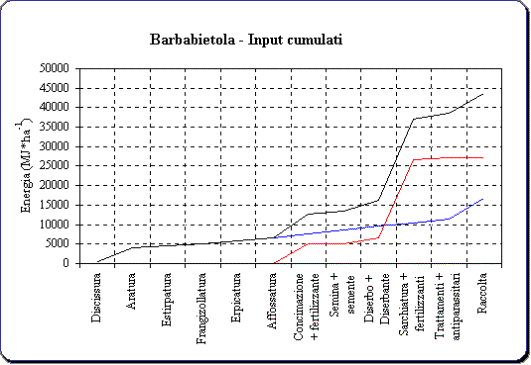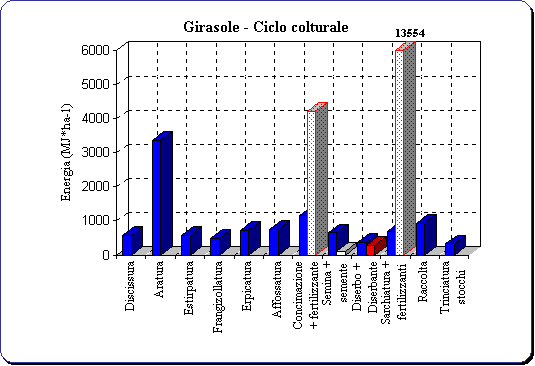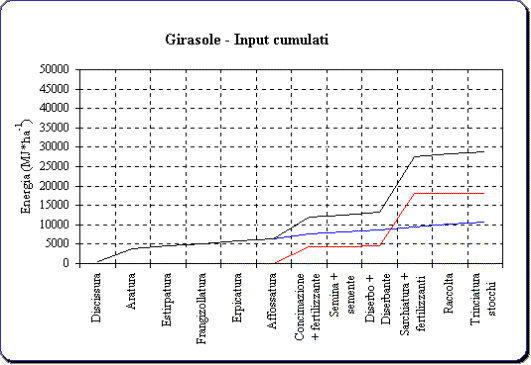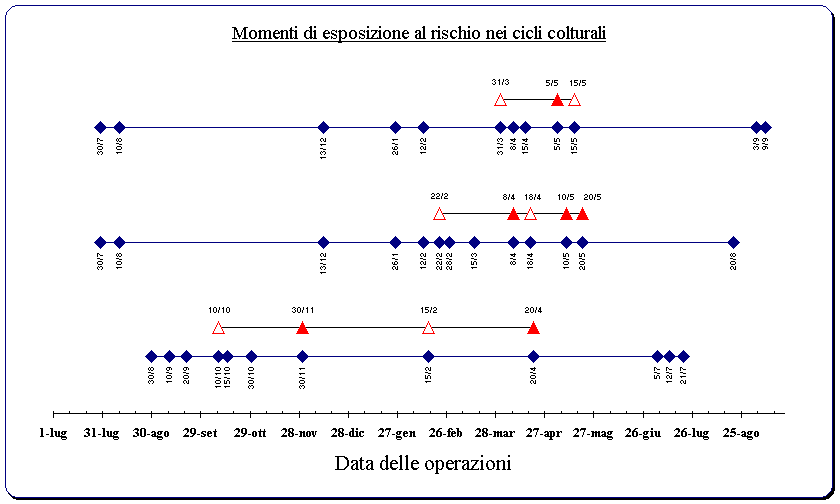|
Progetto
approvato |
|
4.4 Applicazione al caso concreto
Fig. 4.1a – Ciclo
colturale del frumento. Operazioni colturali e quantificazione
energetica dei relativi fattori di rischio.
Fig.
4.1b - Ciclo colturale del frumento. Quantificazione degli input
energetici.
Fig.
4.3a – Ciclo colturale del girasole. Operazioni colturali e
quantificazione energetica dei relativi fattori di rischio.
Perciò
sarà opportuno distinguere gli interventi a seconda della
classificazione di tossicità delle sostanze chimiche distribuite.
Nel nostro caso, ad esempio, si sono distinti gli interventi
di fertilizzazione da quelli di distribuzione di erbicidi,
insetticidi ed antiparassitari in genere. In definitiva, l’applicazione di questa metodologia
al caso concreto ci permette di ottenere la successione nel
tempo degli interventi colturali durante i quali si hanno
le esposizioni dei lavoratori agricoli ai diversi fattori
di rischio, con la stima delle relative intensità; come si
vede nei grafici in Fig. 4.1b, 4.2b e 4.3b, abbiamo anche
una stima dell’impatto ambientale delle tre colture in esame,
espresso in input energetici totali. Successivamente le singole operazioni sono state individuate
in relazione alla data di effettuazione, come si vede nel
grafico in Fig. 4.4.
Fig.
4.4 - Cronogramma degli interventi che comportano rischio
meccanico (rombo blu), rischio chimico elevato (triangolo
rosso) e rischio chimico moderato (triangolo bianco). Questa
rappresentazione consente di prevedere, nell’arco dell’annata
agraria, i momenti in cui si verificano le singole esposizioni
ai fattori di rischio, dandone anche una quantificazione approssimata,
e quindi di impostare una serie di rilievi sulle persone,
sull’ambiente e sui prodotti per controllare gli effetti dell’attività
agricola. La metodologia proposta risulta quindi di facile applicazione,
in quanto consta essenzialmente di una fase di studio in cui
vengono tradotti in termini energetici i dati agronomici delle
singole colture, ed in una fase di applicazione in cui si
utilizzano i risultati dell’indagine per predisporre un programma
di monitoraggio adatto alla situazione specifica. E’ facile
comprendere come tale procedura possa essere applicata alle
diverse colture ed ai diversi settori della produzione agricola. Lo
studio delle problematiche relative al settore dei fitofarmaci
si pone come obiettivi principali la valutazione della quantità
reale di sostanze chimiche distribuita sul territorio e l’individuazione
di processi miranti ad una razionalizzazione dell’uso, anche
in termini di competenza degli operatori. Le norme che regolano
il settore della produzione di sostanze chimiche da utilizzare
in agricoltura, prendono in considerazione la salute umana e
gli effetti ambientali, introducendo complessi test di sicurezza,
soprattutto per le molecole di nuova introduzione; attualmente,
la valutazione degli effetti ecologici e tossici costituisce
uno dei maggiori impegni per le aziende produttrici. L’attuale sistema di controllo, volto soprattutto
a verificare il rispetto in tema di contaminazione delle derrate
alimentari, mostra la necessità di integrazioni a livello locale,
in quanto appare inadeguato in relazione alla complessità ed
all’onerosità del compito cui è adibito. La selezione di aziende tipo, rappresentative dell’intero
territorio provinciale per ordinamento, per dimensioni e per
numero di addetti, permetterebbe di applicare i sistemi di controllo
a situazioni ben determinate. In queste aziende, si dovrebbe
quindi attuare una gestione controllata degli ordinamenti colturali,
in modo da effettuare, tra le altre cose, trattamenti mirati
sulle colture, valutando nel tempo il livello di contaminazione
degli operatori, dell’ambiente e delle derrate. Per essere efficace,
un tale sistema di controllo deve essere necessariamente multidisciplinare,
in modo da garantire una valutazione dei fenomeni legati a ciascun
settore di interesse e delle loro interazioni. Riguardo ai diversi argomenti trattati, le modifiche
da apportare al sistema attuale possono essere suddivise in
tre ambiti principali, affrontando il problema dal punto di
vista: a) delle sostanze chimiche; b) della salute umana; c)
della contaminazione delle derrate. a) La diffusione della difesa chimica delle colture
ha determinato la produzione di un ampio numero di fitofarmaci;
essi si basano su molecole molto diverse tra loro sia dal punto
di vista chimico sia dal punto di vista tossicologico. La continua
immissione sul mercato di nuovi prodotti obbliga ad aggiornare
continuamente le metodiche analitiche; ciò si può fare verificando
gli indirizzi generali dei consumi, soprattutto riguardo ai
nuovi prodotti, ed ai prodotti da utilizzare a dosi molto ridotte.
Per avere un panorama completo di quanto offerto dall’industria
occorre non trascurare le molecole ottenute per coltura enzimatica
ed i prodotti chimici non tradizionali da utilizzare nell’ambito
della lotta integrata. Sarebbe inoltre opportuno sottoporre
ad un attento studio le sostanze coformulanti, la cui tossicità
viene spesso ignorata. b) Per individuare con un sufficiente margine di approssimazione
il livello di esposizione, è opportuno predisporre indagini
mirate ad individuare i comportamenti più diffusi. La finalità
è quella di individuare la reale osservanza delle leggi vigenti
e al tempo stesso valutare le molecole con cui gli operatori
entrano in contatto. Nel contempo, per agevolare la comprensione
degli andamenti delle malattie professionali in agricoltura,
si dovrebbero evidenziare anche le esposizioni pregresse, legate
ai periodi di effettivo svolgimento delle varie mansioni. La
già citata difficoltà del monitoraggio biologico può essere
diminuita solo con la collaborazione degli addetti, con la definizione
di campioni rappresentativi su cui condurre le indagini, e con
la programmazione degli interventi; sarà possibile in questo
modo effettuare analisi mirate ad una rosa ridotta di principi
attivi, oppure selezionare i fitofarmaci potenzialmente più
pericolosi per la salute umana, individuando le molecole a maggiore
tossicità ed i loro metaboliti. Accertamenti mirati sugli organi
bersaglio permetterebbero di avere un quadro più chiaro sugli
effetti che l’esposizione alle varie sostanze chimiche può produrre
sull’uomo. Recenti studi hanno previsto un nuovo sistema di
quantificazione dell’esposizione, potenzialmente in grado di
semplificare le procedure di controllo e sorveglianza sanitaria
delle popolazioni esposte, basato sul dosaggio degli addotti
emoglobinici dei pesticidi. E’ opportuno poi valutare con maggior
dettaglio il rischio legato allo svolgimento di pratiche colturali
“critiche”, come l’utilizzo in serra e in ambienti di stoccaggio,
i trattamenti post-raccolta ed il lavoro svolto in zone dove
sono stati precedentemente distribuiti fitofarmaci. Durante
il periodo del “rientro in coltura”, le normali operazioni colturali
possono essere svolte in assenza di adeguati dispositivi di
protezione individuale, mentre possono essere ancora presenti
sostanze disperse nell’aria e può permanere il rischio di assorbimento
per via cutanea legato al contatto con la pianta. c) L’attuale ampio ricorso all’analisi multiresiduale
sembra motivato dalla mancanza di un rapporto tra strutture
di vendita dei fitofarmaci e strutture di controllo. Le recenti
normative sull’autocontrollo (Delibera regionale 46 del 22 gennaio
2001), pur non riferendosi specificamente al problema dei prodotti
chimici, sostengono una nuova cultura che fonda le sue basi
sulla conoscenza dei rischi. La promozione di un sistema di
tracciabilità dei prodotti dovrebbe tenere in giusta considerazione
i trattamenti fitosanitari effettuati con le diverse sostanze
chimiche, in modo da rendere più agevole la ricerca di eventuali
residui o metaboliti. A livello locale sarebbe opportuno potenziare
il prelievo dei campioni in azienda, in corrispondenza della
maturazione fisiologica dei prodotti. Questo tipo di indagine
comporterebbe senza dubbio un maggiore impiego di forze rispetto
ai campionamenti effettuati in fase di vendita, ma fornirebbe
peraltro una informazione molto più completa. Dal punto di vista analitico è stata più volte
sottolineata la difficoltà di evidenziare la presenza di alcuni
fitofarmaci, rintracciabili solo con analisi specifiche o addirittura
con strumenti dedicati. Al tempo stesso l’uso di prodotti a
dosi molto ridotte determina l’insorgere di problemi di accuratezza
e di precisione nell’esecuzione delle analisi. Sarebbe quindi
auspicabile creare un circuito per il controllo incrociato dei
risultati analitici. L’uso più esteso dei fitofarmaci avviene
certamente in pieno campo, ma non per questo sono da trascurare
gli effetti dei trattamenti post raccolta, volti ad aumentare
i tempi di conservazione del prodotto o a promuoverne la maturazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||